Al bookshop del Monastero dei Benedettini di Catania un incontro tra storia, arte e architettura restituisce nuova luce al lavoro degli architetti e alla loro eredità culturale
Il fondo di Stefano e Sebastiano Ittar, una ricca raccolta di disegni di architettura, vedute di città e molto altro conservata nella Galleria Regionale del Castello Ursino.
Prende spunto da questo materiale il volume Stefano e Sebastiano Ittar. Rappresentare, progettare e costruire l’architettura fra tardobarocco e neoclassicismo (1765-1847) curato da Armando Antista e Alessia Garozzo e al centro dell’incontro che si è tenuto, nei giorni scorsi, al bookshop del Monastero dei Benedettini di Catania organizzato da Officine Culturali.
«Un incontro con gli autori per valorizzare opere strettamente legate al contesto storico e artistico del luogo», ha spiegato in apertura Manuela Lupica, vicepresidente di Officine culturali.
A prendere la parola, ed avviare la discussione, sono stati gli autori del volume Armando Antista e Alessia Garozzo, provenienti da settori scientifico disciplinari diversi, ma appartenenti alla stessa macroarea. La loro collaborazione è nata dai primi passi nel mondo della ricerca durante il dottorato incentrato sullo studio dei disegni di architettura siciliana.
Questo percorso li ha portati a esplorare il fondo Ittar, dalle biografie e vicende professionali di Stefano e Sebastiano alla ricca raccolta di disegni di architettura, vedute di città e molto altro conservati nella Galleria Regionale del Castello Ursino.
Tra i materiali emergono chiaramente le tracce del padre Stefano Ittar e del figlio Sebastiano dando così vita a uno studio parallelo su due figure unite dalla parentela, ma protagoniste di un passaggio cruciale tra tardobarocco e neoclassicismo. Mentre Stefano si muove con coerenza all’interno delle coordinate settecentesche, con riferimenti stabili e una visione radicata, Sebastiano interpreta con lucidità e sensibilità le complesse trasformazioni dell’Ottocento.
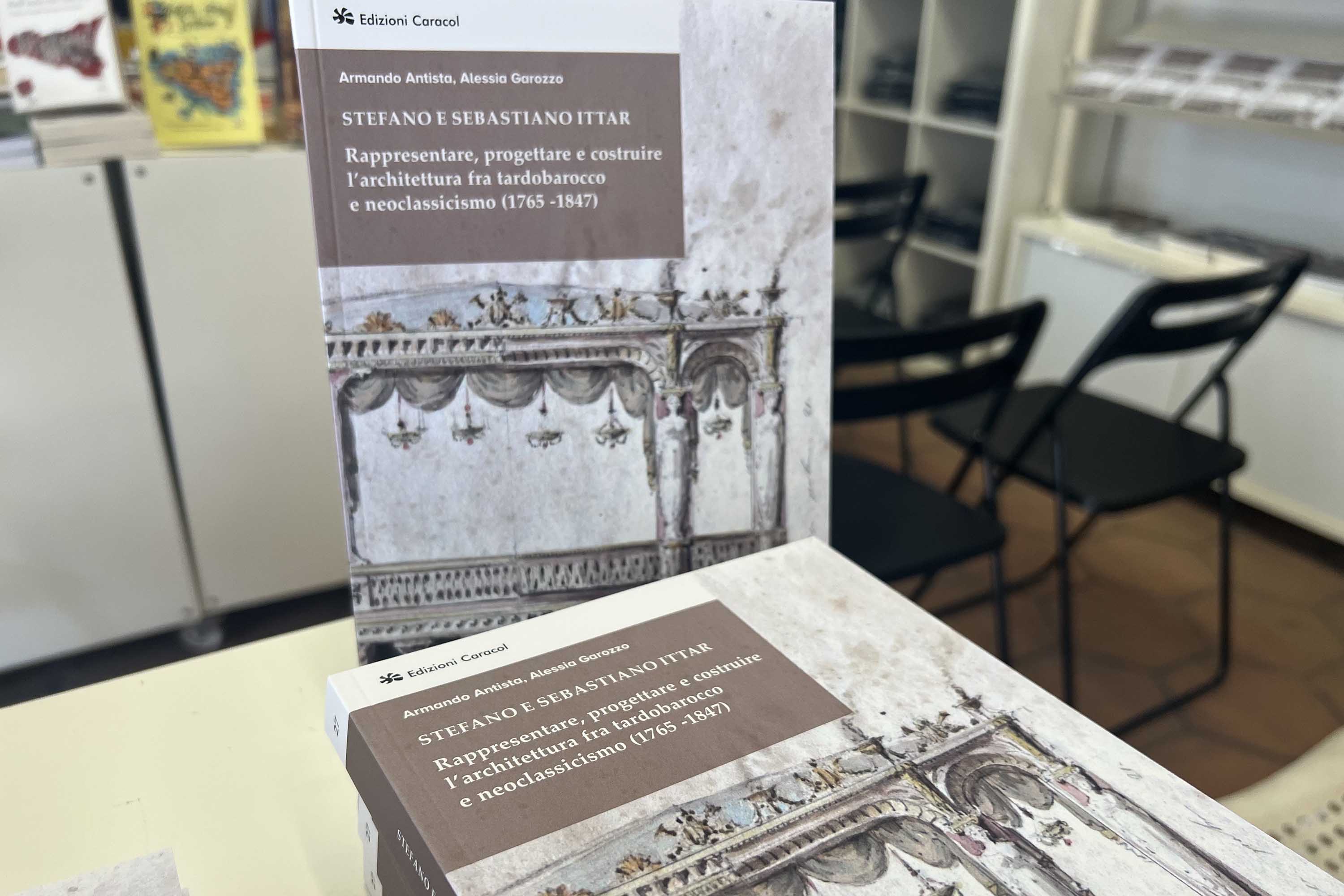
Il volume "Stefano e Sebastiano Ittar. Rappresentare, progettare e costruire l’architettura fra tardobarocco e neoclassicismo (1765-1847)" curato da Armando Antista e Alessia Garozzo
I suoi disegni riflettono influenze lontane - dall’Egitto alla Grecia fino all’Oriente -, ma anche l’irruzione della modernità: nuove funzioni urbane, tipologie edilizie innovative e un’architettura che si apre al dialogo con la borghesia emergente e con i bisogni di una città in rapido mutamento. Questo studio parallelo sottolinea l’importanza di valorizzare questi archivi, custodi preziosi della memoria storica e testimoni di un’epoca in evoluzione.
Attraverso l’analisi dei documenti d’archivio e dei disegni catanesi, come evidenziato dal volume, emergono legami culturali con Roma, il respiro internazionale della formazione e delle committenze di Stefano e rilegge il ruolo di Sebastiano — spesso definito “architetto dell’utopia” — come figura centrale nella trasformazione di Catania nella prima metà dell’Ottocento.
Da sottolineare che Stefano Ittar realizzò la Porta Ferdinandea, l’attuale piazza Giuseppe Mazzini, e la Chiesa della Santissima Trinità. Sono stati attribuiti all’architetto polacco, tra gli altri, nella città di Catania i prospetti della Basilica della Collegiata e della Chiesa di San Placido e, inoltre, la realizzazione della cupola della Chiesa di San Nicolò l’Arena e il largo dell’attuale piazza Dante. A lui si devono il completamento del Municipio di Catania, il prospetto del Priorato della Cattedrale, chiesa e una parte del Monastero della Santissima Annunziata di Paternò e la ricostruzione della cupola della Cattedrale di Noto e il disegno del vestibolo della Chiesa di San Michele in Acireale.
Il figlio Sebastiano, che ricoprì anche l'incarico di architetto del comune di Catania si occupò della progettazione del campanile nord, del rosone e delle restanti decorazioni in stile neogotico del prospetto della cattedrale di Acireale.

La Basilica della Collegiata di Catania
A seguire è intervenuto Eugenio Magnano di San Lio, associato di Disegno al Dipartimento di Ingegneria civile e architettura dell’Università di Catania, che ha sottolineato «l’importanza di un lavoro che restituisce il giusto valore alla produzione grafica e progettuale dei due architetti». «Un’opera che non si limita a raccogliere disegni, ma li analizza con rigore critico e sensibilità progettuale, offrendo una nuova chiave di lettura», ha aggiunto.
«Il volume ci restituisce, non solo le forme, ma anche le intenzioni, le suggestioni e le visioni che li animano – ha aggiunto -. Molti dei progetti selezionati non furono mai realizzati o non sono più visibili. Eppure, proprio attraverso il disegno ci parlano ancora: sono tracce di un’architettura pensata ma non costruita che ci aiutano a comprendere meglio le logiche del progetto e le tensioni culturali del tempo».
Il docente ha concluso il suo intervento ricordando che questo volume «rappresenta un punto di partenza, non di arrivo, perché molti materiali attendono ancora di essere studiati e valorizzati». L’invito, rivolto agli autori, è di proseguire attraverso «un lavoro interdisciplinare che sappia superare le divisioni accademiche per instaurare un dialogo storia, rilievo, progetto e cultura visiva». «Solo così – ha aggiunto – si possono affrontare nel modo più completo e profondo opere complesse come quelle degli Ittar».
«Non solo architettura, ma anche arte e colore», ha ricordato Barbara Mancuso, associata di Storia dell’arte moderna al Dipartimento di Scienze umanistiche dell’Università di Catania. «Mi sono chiesta come mai mi avessero voluto coinvolgere, ma già la copertina del libro non può richiedere esclusivamente lo sguardo dell’architetto, perché gli autori hanno insistito sul recupero del colore che si trova nei disegni, e che non è casuale», ha spiegato la docente.
Parlando di Stefano Ittar, la prof.ssa Mancuso ne ha sottolineato le origini: «È un architetto nato nel Settecento in una regione che allora faceva parte della Polonia. Credo che questo sia il quid che aggiunge un elemento di interesse al libro».
E nel commentare il lavoro degli autori ha detto che «Armando Antista parla di un repertorio di attribuzioni estremamente vasto e solo in alcuni casi suffragato da prove documentarie». «La scelta di selezionare alcune costruzioni più pertinenti deriva anche dal fatto che sono quelle poche documentate, sulle quali ci possiamo soffermare con più sicurezza», ha aggiunto.

Gli autori del volume e i relatori nel corso dell'incontro
Un altro aspetto che Mancuso ha apprezzato riguarda l’impostazione metodologica: «Mi è piaciuta molto l’attenzione al viaggio e allo spostamento degli artisti, perché ogni viaggio è fondamentale per l’apprendimento di modelli da riproporre».
Sul piano strutturale, il libro si presenta come una biografia doppia, ma per la docente la sua articolazione è più complessa: «Apparentemente è un percorso attraverso l’attività dei due architetti, padre e figlio, Stefano prima e Sebastiano dopo». «Ma in realtà non è una semplice biografia: ha un tracciato complesso, con una via principale e poi una serie di approfondimenti affidati a ricercatori giovani e meno giovani», ha aggiunto.
Uno degli aspetti più stimolanti riguarda i disegni ritrovati: «L’aver rintracciato materiali nuovi all’interno del Museo Civico di Castello Ursino dimostra che è uno scrigno pieno di cose ancora da conoscere, da tirare fuori e studiare». «Questa raccolta consistente di disegni è stata ceduta al Comune di Catania nel 1952, ed era già nota nel 2018., ma per lungo tempo i disegni sono stati segregati», ha detto in chiusura di intervento la prof.ssa Mancuso.
Anche il prof. Luigi Pellegrino, associato di Composizione architettonica e urbana al Dipartimento di Ingegneria civile e architettura dell’Università di Catania, ha accolto con entusiasmo la pubblicazione affermando «l’importanza di un volume dedicato alla straordinaria famiglia di architetti Ittar». «Da una serie di prove indiziarie emerge che la cupola della chiesa di San Giorgio di Ragusa Ibla è stata realizzata da Sebastiano Ittar, solo un genio poteva disegnare cupola così particolare a testimonianza della sua modernità e del suo interesse verso lo sviluppo della città, mentre il padre Stefano, in questo confronto generazionale, appare antico».
Soffermandosi proprio sulle opere di Sebastiano Ittar, il prof. Pellegrino ha sottolineato che «il lavoro più straordinario svolto riguarda la prima pianta ortografica realizzata a rilievo della città di Catania». «È un progetto moderno, come quelli che si fanno oggi all’università – ha aggiunto -. Ha progettato lo spazio pubblico». «Disegna in pianta, oltre agli isolati, tutti gli edifici principali come il Duomo, i palazzi e le chiese e riporta quasi tutti i frammenti della città antica – ha precisato il docente del Dicar -. In alcuni casi li disegna in numero maggiore rispetto a quelli visibili, quindi è un disegno falso, ma è la restituzione di un’idea di città».