L’incontro, tra passato e presente, si è tenuto al Palazzotto Biscari nell’ambito dell’iniziativa “Caffè scientifici”
Al Palazzotto Biscari dell’Università di Catania, nei giorni scorsi, si è svolto il seminario Naturalisti dell’Accademia Gioenia e faune insulari della Sicilia: un viaggio storico.
Una iniziativa organizzata nell’ambito del ciclo di appuntamenti Caffè scientifici promossi dall’Accademia Gioenia in collaborazione con il Dottorato in Scienze della Terra e dell’Ambiente dell’Università di Catania proprio per rafforzare il legame tra formazione avanzata e patrimonio scientifico universitario. Da semplici fruitori di conoscenze, i dottorandi diventano i veri protagonisti delle ricerche.
Protagonista dell’incontro è stato Gianmarco Minniti, dottorando al terzo anno sotto la supervisione della prof.ssa Rossana Sanfilippo, che ha accompagnato e introdotto la presentazione, ringraziando i soci e gli amici dell’Accademia per la frequente partecipazione alle attività organizzate, e sottolineando l’importanza dell’accordo di collaborazione tra il Dottorato e l’Accademia Gioenia per dare spazio e visibilità ai giovani ricercatori.
Collezioni storiche e nuove ricerche
Il seminario si è costituito di un vero e proprio viaggio nel tempo attraverso le collezioni storiche del Museo di Paleontologia dell’Università di Catania. Reperti raccolti e studiati già dalla prima metà dell’Ottocento da naturalisti e soci dell’Accademia Gioenia, come Giuseppe Alessi o Andrea Aradas, sono stati riletti oggi con uno sguardo moderno.
Dalla collezione malacologica del prof. Sebastiano Italo Di Geronimo ai depositi ossei di Grotta Spinagallo e Grotta Santa, ogni insieme di fossili racconta una storia: quella delle faune insulari che popolarono la Sicilia e il Mediterraneo, tra ippopotami nani, elefanti ridotti di taglia e cervidi peculiari. Le collezioni della Sicilia dialogano con quelle di altre isole mediterranee come Malta, mostrando parallelismi e divergenze nell’evoluzione delle faune insulari.
Queste collezioni mostrano come la paleontologia non sia un archivio immobile, ma piuttosto soggetta a continua reinterpretazione. Dalle indagini pionieristiche di Alessi o Aradas, fino agli scavi condotti negli anni ’50 da Bruno Accordi nella Grotta di Spinagallo, da cui emersero dei resti di ippopotami siciliani, alcuni affetti da patologie ossee studiate con metodiche medico-veterinarie, il focus della ricerca rimane la valorizzazione del patrimonio paleontologico siciliano.
Sempre focale nel rapporto di simbiosi tra tradizione e modernità è l’ausilio di tecniche di ricerca che sfruttano le nuove tecnologie all’avanguardia in un connubio interdisciplinare: dall’uso della tomografia computerizzata allo studio isotopico, fino all’integrazione con modelli paleoambientali. La ricerca contemporanea costruisce su basi teoriche del passato, proiettandole verso nuove frontiere di studio.

Il Museo di Paleontologia dell'Università di Catania
La regola di Foster, forme di nanismo e gigantismo
Al centro delle ricerche vi è la regola di Foster, o regola dell’insularità, che descrive i fenomeni di nanismo e gigantismo insulare. In contesti isolati, dunque con risorse limitate, alcune specie tendono a ridursi di dimensioni, come gli elefanti nani siciliani, mentre altre, in spazi ristretti e in assenza di predatori, crescono fino a proporzioni sorprendenti, come gli uccelli elefante (Aepyornis maximus) del Madagascar. Minniti ha illustrato esempi tratti dai suoi viaggi di studio in Madagascar e nelle isole mediterranee, collegando le osservazioni sul campo con le ricerche in museo.
“Le collezioni non sono soltanto resti fossilizzati, ma archivi viventi che ci permettono di rileggere la storia dell’evoluzione e di confrontarla con le conoscenze moderne”, ha sottolineato Minniti nel corso del seminario. Il fenomeno non riguarda solo i grandi mammiferi. In Sicilia e nel Mediterraneo compaiono anche rettili come camaleonti nani o forme ridotte di anfibi, così come invertebrati di piccole dimensioni: un mosaico di adattamenti che dimostra come ogni isola sviluppi regole proprie.
La Sicilia nel Pleistocene: due isole che diventano una
A testimoniare il profondo legame tra la terra e la sua fauna è il legame tra la regola di Foster e la paleogeografia della Sicilia nel Pleistocene. All’inizio del Pleistocene medio, l’isola era piuttosto divisa in due grandi isole separate, abitate da comunità faunistiche differenti. Questa frammentazione geografica favorì l’evoluzione di forme endemiche come ippopotami nani, cervidi peculiari.
Alla fine del periodo, con il picco glaciale, l’abbassamento del livello del mare permise la fusione dei due blocchi, creando nuove connessioni e mescolanze faunistiche. Questi “complessi faunistici” sono fondamentali per comprendere come i cicli climatici abbiano avuto effetti sulla biodiversità insulare.
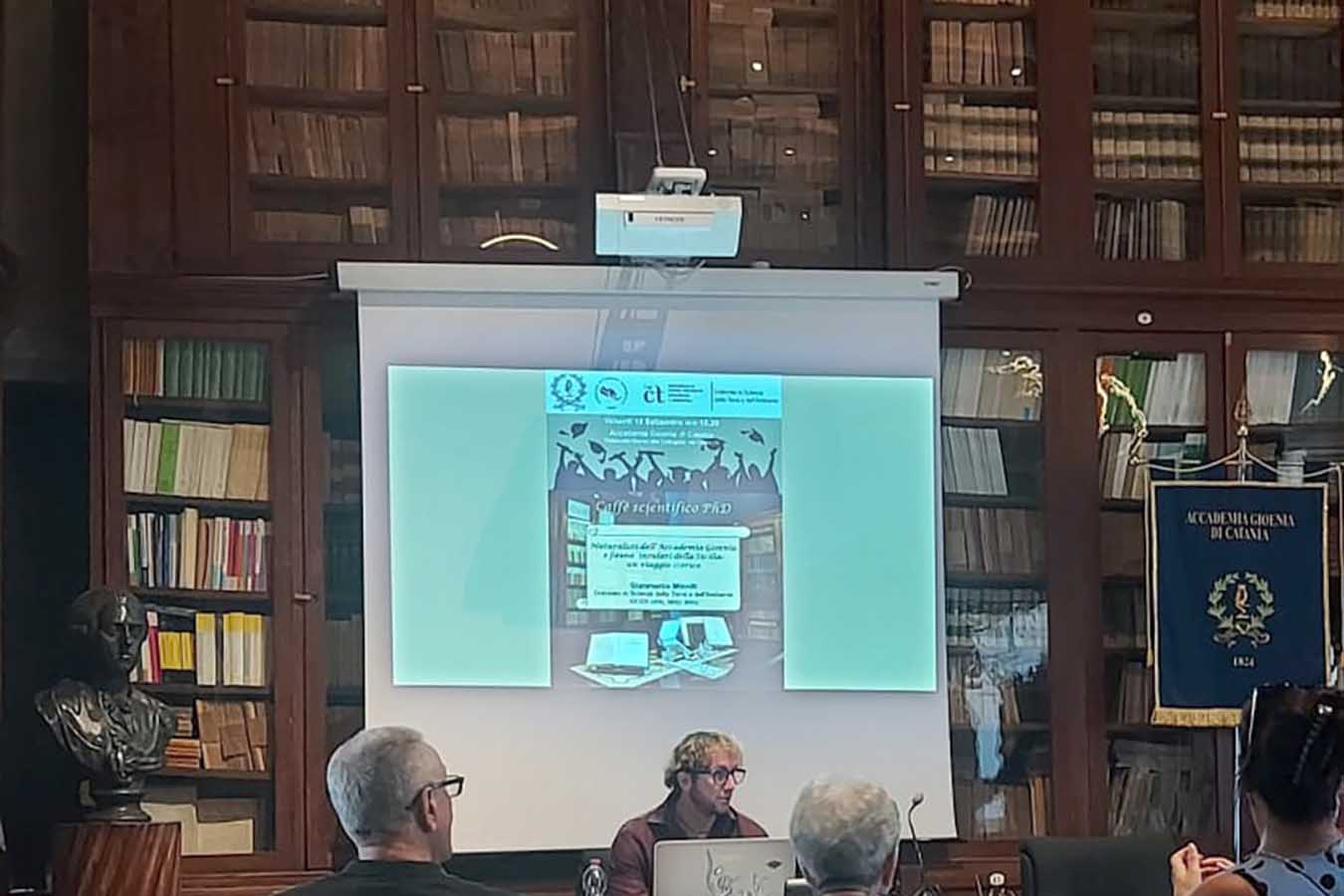
Un momento dell'incontro
Tra mito, storia e scienza
Lo studio dei reperti porta a scoperte non solo di tipo scientifico, ma anche culturale. Gli scheletri di elefanti nani, caratterizzati da una grande cavità cranica, potrebbero aver alimentato nei secoli il mito dei Ciclopi, come Polifemo, ricordato da Omero e reinterpretato da autori come Boccaccio e Tommaso Fazello. La paleontologia si intreccia così con la “gigantologia” letteraria, offrendo una nuova chiave di lettura per comprendere l’immaginario mediterraneo.
Non a caso, già studiosi come Hoffman o Aradas, nel XIX secolo, guardavano alle grotte della Sicilia orientale come archivi naturali che collegavano resti animali, interpretazioni bibliche (diluviane o creazioniste) e la nascente teoria evoluzionista. Alcuni, come Falconer, mutarono il proprio pensiero passando dal creazionismo all’evoluzionismo dopo il confronto con Darwin.
Giovani ricercatori protagonisti
L’iniziativa, come ha sottolineato la prof.ssa Rossana Sanfilippo, mira a offrire ai giovani studiosi la possibilità di presentare i propri risultati non solo alla comunità accademica, ma anche a un pubblico più ampio, in linea con la divulgazione dell’Accademia Gioenia. Un’occasione che conferma l’importanza della collaborazione tra ricerca universitaria, memoria storica e divulgazione scientifica, e che incoraggia le nuove generazioni a guardare al futuro, conoscendo le proprie radici passate.