Meditazione e preghiera in occasione del Festival Biblico tenutosi anche nella città di Catania e che ha visto la rilettura dei Salmi come momento di riflessione su sé stessi
Il Libro dei Salmi, cuore pulsante dell’Antico Testamento, è una raccolta poetica e spirituale che dà voce alla molteplicità dell’esperienza umana. Composto da 150 componimenti di diversa natura – inni di lode, lamentationes, preghiere, ringraziamenti e riflessioni sapienziali – il Salterio riflette l’intera gamma delle emozioni e delle tensioni interiori che l’uomo attraversa nel suo rapporto con Dio, con il mondo e con sé stesso.
Si è conclusa la 21ª edizione del Festival Biblico, incentrata, appunto, sul tema Salmi. Libro infinito, e di cui Catania è stata tappa privilegiata. Le giornate catenesi sono state scandite da dialoghi biblici, meditazioni poetiche e concerti: momenti di intima riflessione alla ricerca del senso dell’esistenza.
Nel cuore della Bibbia, tra inni di lode e suppliche disperate, il Salmo 8,4 (nella numerazione ebraica, difforme da quella greca nella LXX e de quella latina nella Vulgata) si distingue come un’antica meditazione sull’identità umana. Il versetto 4 – “Che cosa è l’uomo perché te ne curi, il figlio dell’uomo perché te ne dia pensiero?” – risuona oggi con una forza inattesa, nel contesto di un mondo in cui la centralità dell’essere umano è messa in discussione da cambiamenti climatici, intelligenze artificiali e nuove vulnerabilità sociali.
A meditare su questo salmo, don Antonino La Manna, presbitero e Vicario per la cultura della diocesi di Catania, e Arianna Rotondo, docente di Storia del cristianesimo e delle chiese nell’Università di Catania, accompagnati da un pezzo di Giuseppe Sanfratello, etnomusicologo nello stesso ateneo.
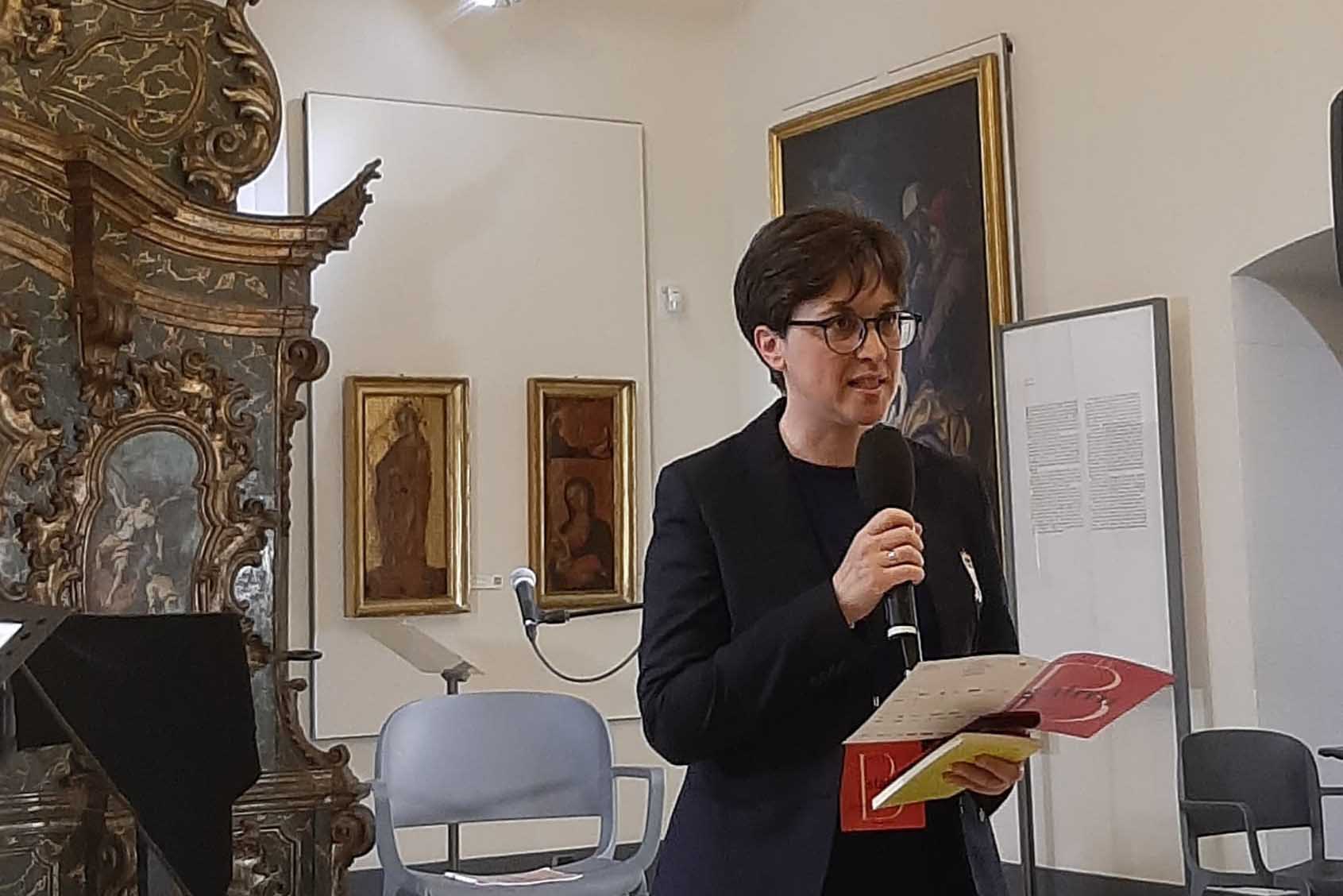
Un momento dell'intervento della prof.ssa Arianna Rotondo
«La narrazione si colloca all’interno di un conflitto – ha ricordato Padre La Manna – in cui Adonai (appellativo di Dio nell’Antico Testamento), ordinatore cosmico, spazza via i suoi nemici, ponendo baluardi che loro mai potranno superare».
Nell’esaltazione della ieraticità del divino potere, «Dio ha ricamato il tessuto prezioso del cielo», e il salmista colto dallo stupore contemplandolo, si domanda come sia possibile che Dio si interessi all’uomo, così piccolo rispetto alla vastità dell’universo. Qui la parola “uomo” si trova nell’ebraico enosh e poi adam. Il termine enosh designa l’essere umano nella sua fragilità, nella sua mortalità, l’uomo nella sua condizione caduca.
Espressione parallela, spesso sinonimica, ma con sfumature diverse, adam indica l’uomo nella sua origine terrestre, figlio dell’argilla (adam deriva da adamah, “terra”; come il latino homo da humus): il parallelismo rafforza l’idea della piccolezza e insignificanza umana rispetto al cosmo.
Il Salmo 8 permette all’autore di meditare sull’infinita maestà del creato e sul mistero dell’attenzione divina verso l’essere umano, facendo sì che «una contemplazione – ma anche un’invocazione – abbia parole che risuonano oltre il tempo e lo spazio», ha commentato la professoressa Rotondo. La riflessione del salmista, come ciò che suscita la sua lettura, è sovrapponibile alle parole pronunciate dal coro nel primo stasimo dell’Antigone di Sofocle.
Il tragediografo greco presenta una visione dell’uomo centrata sulla sua potenza tecnica in una tensione drammatica tra forza e dismisura, tra civiltà e hybris. «Già nel primo verso dello stasimo (v.332) – ha continuato la docente – troviamo racchiuso il cuore del messaggio, Πολλὰ τὰ δεινὰ, ovvero “Molte sono le cose straordinarie”, dove quest’ultimo termine è ambivalente: può indicare sì cose straordinarie, ma anche terribili e mostruose».

In entrambe le opere, la fragilità non è debolezza pura, ma un nodo drammatico, un punto di intersezione tra ciò che l’uomo è e ciò che potrebbe diventare, verso l’elevazione o verso la rovina: l’essere umano può scegliere come utilizzare i suoi talenti.
Nel silenzio delle nostre giornate affaticate, le parole del Salmo 116 ci offrono un sentiero per rientrare in noi stessi e ritrovare un senso più profondo dell’esistenza. Questa è l’esperienza della poetessa Elisa Longo, che ci ha guidato in un movimento profondo: dalla paura alla fiducia, dalla solitudine alla comunione, dal grido alla lode.
Il racconto di un'esperienza umana universale – l'incontro con il limite, il rischio della disperazione, la possibilità della salvezza – illuminata dalla certezza che Dio non è distante, ma vicino, compassionevole, attento. Il monologo è stato introdotto da Arianna Rotondo con le musiche di Giorgio Caporale.
Una voce femminile quella di Elisa Longo, sola ma non isolata, ha attraversato la scena come un’eco intima che si apre lentamente al mondo. È stato il frutto di un lungo itinerario di consapevolezza: un monologo che nasce dall’ascolto profondo di sé, dalla necessità di guardarsi dentro, spogliandosi delle maschere e delle difese.

Giorgio Caporale ed Elisa Longo
Con lei prende forma un viaggio che è insieme movimento fisico e trasformazione dell’anima, radicato in una Calabria concreta e aspra, ma al tempo stesso trasfigurata in luogo simbolico, soglia verso un altrove spirituale.
È in questo spazio sospeso tra terra e spirito che si innesta la voce del Salmo 116 – “Ho creduto anche quando dicevo: sono troppo infelice” (v.10) – che non viene semplicemente recitato, ma attraversato, vissuto, trasformato in carne e parola poetica.
Il salmo diventa così mappa e specchio: racconto di una salvezza invocata nel dolore e riconosciuta nella gratitudine, ma anche eco di un’esperienza personale che ne rinnova il senso, restituendolo al presente con fragilità e luce. Il monologo si fa allora invocazione e testimonianza: il dolore non viene eluso, ma accolto, trasfigurato in parola che cerca relazione.
La forza dei Salmi risiede nella loro capacità di esprimere senza censure la complessità dell’animo umano: dalla gioia alla disperazione, dalla fiducia alla protesta, dalla gratitudine alla ribellione. In questi testi si trovano espressioni di esultanza spirituale, ma anche grida angosciate che mettono in discussione il silenzio e l’apparente assenza di Dio.